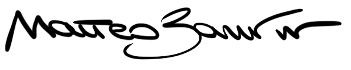“Nella stanza chiusa”, di Frances Hodgson Burnett – la recensione
 Nell’estate del 1903, in soli quattro giorni, Frances Hodgson Burnett concepisce e scrive Nella stanza chiusa, un racconto lungo suddiviso in due parti che affronta i temi della prematura dipartita dalla vita terrena e delle morti infantili. Germogliato, con ogni probabilità, dal dolore che la scrittrice ancora covava dentro il proprio animo, generato dalla morte del primogenito Lionel (avvenuta nel 1890 a causa della tisi), Nella stanza chiusa si sviluppa a cavallo tra il realismo e la ghost story.
Nell’estate del 1903, in soli quattro giorni, Frances Hodgson Burnett concepisce e scrive Nella stanza chiusa, un racconto lungo suddiviso in due parti che affronta i temi della prematura dipartita dalla vita terrena e delle morti infantili. Germogliato, con ogni probabilità, dal dolore che la scrittrice ancora covava dentro il proprio animo, generato dalla morte del primogenito Lionel (avvenuta nel 1890 a causa della tisi), Nella stanza chiusa si sviluppa a cavallo tra il realismo e la ghost story.
Judith – la giovane protagonista di queste pagine – si trasferisce nella dimora signorile di una famiglia che necessita di custodi per le proprie mura domestiche. La ragazzina ottiene piena la libertà di movimento e la possibilità di ispezionare ogni angolo della casa, eccezion fatta per la “stanza chiusa“, il cui interno è precluso a chiunque.
La gente ha sempre qualcosa che vuole tenere chiuso a chiave.
Ma Judith è troppo giovane per poter aver assimilato un simile concetto – una consapevole salvaguardia che si impara solo con lo scorrere degli anni – e la sua acerba curiosità la spingerà a muoversi oltre i confini che le erano stati imposti, spingendosi verso quello che inizialmente appare come un denso sogno da cui la ragazzina fatica a uscire (Svegliati Judith; sei fuggita in un sogno?). Ed è proprio sotto la protezione di questa convinzione che la giovane riesce a perpetrare le sue visite nella “stanza chiusa” – per lei sempre aperta – in compagnia della misteriosa bambina con la quale inizia a stringere un rapporto amicale e complice.
Ella non sa che non è affatto reale.
In questo scenario misterico si introduce, quindi, il tema della morte – che la stessa autrice, quando si accinge a iniziare la stesura del testo, ha ancora da interiorizzare, accettare e comprendere – già presente nell’incipit de Nella stanza chiusa: Judith e la sua famiglia, infatti, sembrano più che abituati all’incontro con l’aldilà. La cara zia Hester, scomparsa da poco, pare abbia una predilizione nei confronti della piccola nipotina, la quale non nasconde di vederla apparire spesso in sogno:
Ma non sono addormentata quando vedo zia Hester – ha detto. Mi ridesto. È più desto lì che qui.
Una sorta di richiamo, un Destino segnato, anticipato e predetto – forse? Quel che è certa, una volta che si giunge alla conclusione, è la connessione viscerale che esiste tra il mondo dei vivi e la terra degli spiriti. Un legame che ha la forma di un portale, di una soglia, di un “altrove” che va attraversato; e al quale è praticamente impossibile opporsi, quando il suo richiamo si accende, propagandosi suadente dall’angolo più nascosto delle stanze che abbiamo il timore di abitare.
Nella stanza chiusa si è rivelata una breve lettura che mi è piaciuta; l’ho trovata, al contempo, malinconica e un po’ creepy, rassegnata e vibrante. Un racconto che tratta un tema non lieto, ma che non lascia nel lettore una sensazione negativa o troppo triste. Sembra quasi che la Burnett voglia farci intendere di essere finalmente giunta – al termine della storia – a un’accettazione fatalista del Destino mortale dell’umanità e di essere riuscita, dopo quattordici anni, a scendere a patti con l’abbandono prematuro del suo piccolo Lionel.
Un plauso, come di consueto quando si parla della collana de I Classici Ritrovati di Caravaggio Editore, va alla traduzione e alla cura di Enrico de Luca, a cui è andato ad affiancarsi Giordano Milo. L’edizione proposta da Caravaggio Editore, inoltre, si impreziosisce grazie alle suggestive tavole originali (a colori!) presenti in appendice al volumetto.
Una grande casa abbandonata da coloro i quali avevano riempito le sue stanze di emozioni e di vita, esprime un silenzio, una peculiarità tutta sua. Una casa non ammobiliata e vuota sembra meno incredibilmente silenziosa. Il fatto che sia priva di suono è tutto sommato più naturale. […] Tutte queste cose quando vengono lasciate sole sembrano attendere in uno strano stato di arresto, come sotto un qualche incantesimo che intensifica l’effetto di pausa nella loro esistenza.